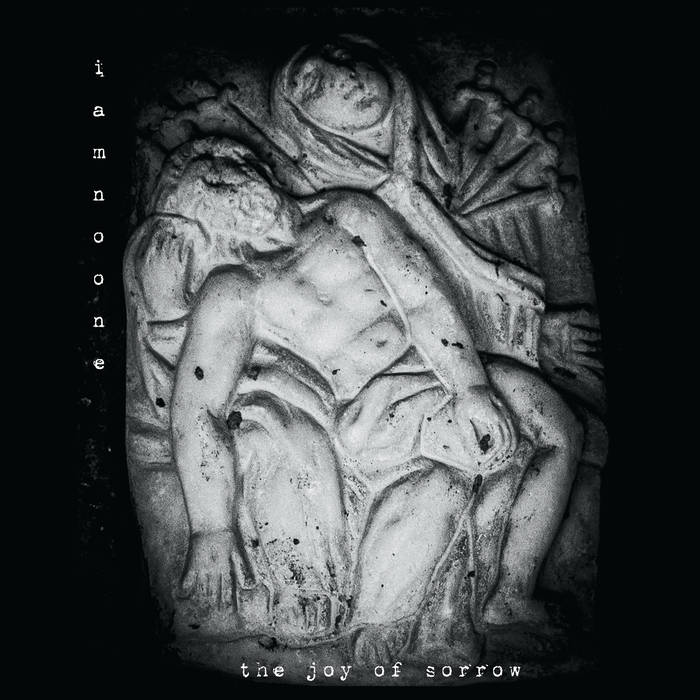Desperate Journalist - No Hero
Ci sono graffi velati di nostalgia nelle corsie affollate di Londra, città che è tornata a dominare la scena in questo 2024, che in modo spavaldo si espandono attraverso una precisa documentazione che prevede tossine pop in dosi abbondanti, per recuperare il tempo. E questa band, al suo quinto lavoro, riesce nel suo personale vertice descrittivo a completare un lungo percorso, approcciandosi in modo garbato a uno stile sempre più noir ma con l’accuratezza di deviare in nuovi posti, facendo un uso importante di tastiere e sintetizzatori, con testi in grado di far comprendere che, se esiste un luogo dove la musica può essere ascoltata e vista con queste composizioni, tutto viene agganciato con estrema precisione. Il raggio di azione, variopinto, educato, morbido, nei confronti di generi che derivano da antiche presenze, con nomi altisonanti a fare da garanti (The Cure, Cranberries, Saint Etienne, Black Box Recorder in primis), è solo uno spunto, una scusa, una mossa strategica, un impermeabile nel quartiere di Soho per solleticare, ingiustamente, ogni tentativo di comparazione e classificazione.
I quattro pirati dell’umore sono invece intenti a fare delle note un pallottoliere da mettere nel disagio delle intemperie dei sensi, con quella drammaticità che scavalca ogni possibile allineamento e agganciamento da parte nostra: non c’è posto in questo avamposto caratteriale per una identità che si finalizzi nella comprensione.
La Les Paul di Rob Hardy è una sintesi pirotecnica di frammenti jingle jungle, di effusioni dream pop, con una catarsi post-punk tenuta splendidamente centrata più sulla perpendicolarità del suono che non sulle sue curve. Ed è estasi, una gioia che si alza in piedi anche grazie a Caroline Helbert (chiamatela Caz, per cortesia), una batterista prestata alla bellezza delle nuvole vaganti con le sue strategie continue per fare, del ritmo, una corsa spesso aiutata da patterns che sembrano intensi in modo spudorato. Simon Drowner suona il basso come se fosse invitato a prendersi la responsabilità di dare una forma grassa alle corsie gravitazionali di Jo Bevan, la miglior interprete del noir pop al giorno d’oggi, senza alcun dubbio.
Notevole l’apparente distacco dalle produzioni precedenti: ogni brano sembra un episodio a sé, un atto talmente unico di presenza, che, in modo per nulla forzato, una volta che gli altri gli gravitano attorno, tutto prende senso. Nessun concept bensì un ancorare la necessità artistica a una esibizione melodica che consenta richiami, appostamenti e una gran voglia di isolamento, tra danze e riflessioni perpetue.
Gli assoli, per esempio, sono inglobati per sottolineare l’umore, il suo versamento doloroso, la sua fragranza dentro un’alchemica presenza del fattore onirico, costante da sempre nella band londinese, ma che in questo disco sembra davvero strappare le lacrime dal nostro petto.
Sussurri, vibrazioni tra chitarre elettriche ritmiche e arpeggiate si trovano assembrate nel cilindro, sottile, di una morsa stretta causata dall’uso sapiente di elettronica, che, alla fine dell’ascolto, riesce a ottenere un sottile effetto.
Si viaggia con l’alternative, il post-punk, il post-rock, il dream pop e anche gocce di psichedelia sino a giungere persino al progressive. Tutto ciò accade mentre il lato orecchiabile, di facile presa (per intenderci: i ritornelli) è tutto irrimediabilmente sexy e gonfio di ridondanze fertili di gioia.
Ma davvero non si può negare come l’ascolto costi impegno, con la digestione di alcuni momenti che ci fa compiere un piacevole sforzo: gli artisti non cedono, non si fanno abbindolare nemmeno dalle loro stesse intenzioni prima di scendere in studio. Sì al pop ma con raffinato rispetto nei confronti del loro passato, delle miglia e ore percorse per incrociare lo sguardo con le nostre emozioni.
Da notare come il suono, pulito e diretto, sia in contrasto con il drumming, sofisticato, talvolta jazzato, in un circuito di affluenze che tendono a incidere sulla complessità, regalando un necessario studio.
La potenza evocativa dei testi ora vive un matrimonio inossidabile con Jo: questa voce è capace per davvero di fare ciò che negli anni novanta avevano tentato di compiere Björk e Dolores O’Riordan. Lei riesce a girare attorno al senso modulando e flirtando spesso con leggeri cambi di registro, risultando sempre credibile ancora prima che le parole si depositino nella nostra comprensione, come se sapesse precedere noi e il nostro diario di appunti.
Coralità, enfasi, dramma, tensione e una valanga di graffi escono dalla sua bocca con la musica che tenta di fare da fermaglio, fallendo (nel senso benevolo dell’espressione), e risultando abile, invece, nel farci intendere quanto i quattri siano coesi molto di più rispetto ad altre band più note e ammirate.
I temi descritti e la modalità paiono giungere da un passato che ha una lente di ingrandimento su ciò che accadrà: la parte più drammatica di queste composizioni sembra un party triste mentre i fuochi d’artificio impazzano nel cielo…
Un lavoro clamoroso per integrità, per una identità che non ha il visto per il successo, data l’ignoranza della massa, ma che rende il loro operato un oscar al merito artistico…
Ora è tempo di addentrarci in questo disco, canzone per canzone, per raccogliere lo stupore e dargli il giusto scettro…
Song by Song
1 - Adah
Le chitarre di Seventeen Seconds dei Cure aprono le danze, mentre la voce dell’angelo Jo preferisce dirottare e incunearsi nella dimensione di una tempesta di vento con le sue ascese e discese. Una compattezza biblica circonda le poche note del synth e della sei corde di Rob Hardy che passa anche dalle parti di Johnny Marr. Tesa, nervosa, con una velenosa impronta che toglie il fiato…
2 - No Hero
C’era una volta il C-86, poi Dream pop, e vi erano atmosfere che prevedevano treni veloci per poter arrivare ai ritornelli con esuberanza. Ed è quello che accade qui, con la voce che allunga le parole come il drumming di Caz Helbert che sa come frustrare i compagni di questo viaggio davvero malinconico. La chitarra nel finale ci riporta agli Au Pairs e ai Cranberries, in una unione imprevista e calamitosa…
3 - Afraid
Simon Drowner è un bassista dalle dita angeliche, in grado di tenere in piedi un tratto melodico, sino a farlo divenire la corsia su cui Caz e Rob costruiscono un gioiello dai sentimenti anni novanta, per poi scendere in un dramma meraviglioso con il pianoforte che tratteggia un dispiacimento raccolto in una danza quasi muta…
4 - Comfort
Pet Shop Boys, Erasure e Yazoo: tre vecchie entità vengono ricordate in questo brano, con i loro movimenti pop, e la sensazione che il lato elettronico sia più caloroso di una ballad… Una progressione lenta ma inesorabile verso il ritornello, dove tutto si compatta in una contemporaneità inimmaginabile all’inizio.
5 - Silent
La chicca, la superstar, la regina di cuori che esce e fa stragi per il mondo: quando la decadenza cerca il silenzio ecco uscire queste note in cui la chitarra accenna a rivisitare momenti eccelsi della 4AD, per poi allontanarsi e cercare un fuoco più morbido. Il cantato è un'opera d’arte, tra vibrati e corde tese, gonfie di allucinanti condensati di verità, che distruggono ogni illusione. Triste come solo il pop sa essere, questa perla offre anche una tastiera piena di sangue e chitarre vicine agli Alan Parson Project, per fare un perfetto girotondo musicale…
6 - Underwater
Il momento più laborioso, la scintilla artistica che accende il senso, la gravità, la magnificenza, si mostra con questo impeto dove tutto sembra sincopato, elettrico, non disponibile a una conversione piacevole. Accenni di chitarre post-punk che cercano l’ombra, nel mare splendidamente tossico di questa base elettronica che, con un pattern industriale, esalta l'atipicità di questo episodio rispetto agli altri.
7 - 7
Il Dream pop dentro l’horror, in uno specchio vitaminico con sfumature grigie, in cui i Cranberries sembrano i nipoti di tentativi di approccio, mentre gli Echobelly tracciano la potenza e la robustezza di uno scheletro armonico davvero impervio ma esaltante…
8 - Unsympathetic Parts 1 & 2
Il brano più lungo dell’album è un lampo chiaro e scuro, un incredibile e gioioso nonsense all’interno di un circuito emozionale che cerca e trova dilatazioni e cambiamenti, per giungere nei pressi di un delirio dove il ritornello è un decadente soffio algebrico scandito, di grandi volumi e intensità. Poi tutto torna a essere nebbia in Trafalgar Square, in un giorno di pioggia…
9 - You Say You are Lonely
L’album di debutto sembra ricordarci la provenienza di questi ragazzi ormai adulti mai concessisi alla resa dell’impronta stilistica: un’atmosfera accennata, in cui la voce fa da timoniere iniziale, per farci abbandonare alla nota unica di un pianoforte davvero ebbro di cupa luce, e poi si muore in questa bellezza fertile che trova un ritornello così lontano dai giorni nostri…
10 - Consolation Prize
Le band serie mettono sempre il momento migliore all'ultimo atto: se un commiato deve esistere che sia grandioso…
Consolation Prize è il battito di ciglia dei Big Country nelle chitarre e dei Chameleons, la linea melodica è un’ovazione diretta ai Cure fintamente allegri, con la voce che ci ricorda da vicino la cantante di una band molto amata da Robert Smith, gli All About Eve …
Misteriosa, graffiante, trova la capacità nel ritornello di essere devastante mentre il fazzoletto si riempie di acqua santa, grazie al sottile vertice no wave che si appiccica a più vistose metodiche pop dei primi anni Ottanta…