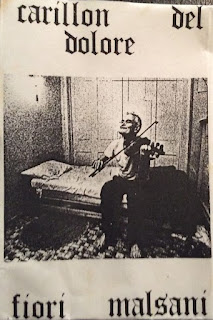Adrian Borland - The Scales Of Love And Hate
La memoria scende nel cuore per fare ordine, per una reale necessità, per dare un senso che viva per i giorni a venire. L’amicizia vera tra gli uomini è cosa possibile, rimane anche quando qualcuno lascia questo pianeta. E in questa circostanza il cuore si fa pesante, ma ricordare è mantenere quella vita in viaggio perenne proprio qui, in questa fiumana di lacrime instancabili.
Un disco non potrà mai sintetizzarne la profondità, ma ne testimonia in parte il cammino e i suoi arcobaleni, imprendibili.
E allora finisci col mettere i tuoi pensieri dentro le riserve segrete di due esseri che si sono confrontati, amati, supportati, con il talento a sostegno di entrambi, con quello di uno dei due che è già nel cielo con la sua voce piena di piume e graffi, mentre l’altro lo ricorda, portando avanti il suo nome per fissarlo il più possibile nel cuore di molti.
Adrian Borland e Carlo van Putten sono l’abbraccio di cui necessitano le anime piene di riconoscenza e amore vero. E c’è un album in arrivo che sussurra l’invito ad adoperare la curiosità, l’affetto, la giusta misura di rabbia e nostalgia, la volontà di non staccare mai la spina dal guardare il cielo alla ricerca della chioma di Adrian e della sua classe, che ha già il suo spazio sul palco degli assi.
Non è una raccolta con tre inediti: direi, piuttosto, la sua esistenza messa a nudo, con semplicità, attraverso la modalità che gli restituisce, eternamente, l’ingresso nella nostra famelica accoglienza, per accompagnarci perché è lui ad amarci, a essere a nostra disposizione.
Cosa serve a un fuoriclasse per rimanere eterno? La sua nudità, senza abbellimenti, sovrastrutture, arrangiamenti, perché la genialità sta nella visione di una cellula, che quasi segretamente prende possesso di un intero corpo.
Sono dita che planano sulle corde con maestria, eleganza, necessità, trascinandosi una voce che tutte le volte ipnotizza, commuove e suscita sommosse senza fine. Adrian è l’ultimo fuoriclasse a testimoniare come la giustizia non sia cosa umana, come il gusto e le scelte musicali siano stupide, banali e violente.
Intanto lui è un oceano di bellezza che non dorme mai, come le onde, sempre in moto, presente, a disposizione.
Ventidue canzoni che sono stordimenti e schiaffi per chi, amandolo, sente la struggente impotenza davanti al terremoto interiore che l’ha fatto franare. Non si è negato a noi ma a se stesso, nel furore di complessità che non possiamo conoscere e tantomeno giudicare.
Allora lo si ascolta, come assiderati dal suo calore unico, perché nelle sue canzoni (qui nello stato pulsante della nascita, quando nulla occorre se non apparire) c’è il suo volo, il suo tremare, il termometro e il goniometro della sua intensità, che è la sua bellezza, umana e artistica.
Si frana mentre le orecchie assorbono, captano suoni e liriche che si fanno un tutt’uno, indivisibile e perfetto.
Emergono, incolonnate in una splendida scelta della scaletta, ventidue petali di seta che avvolgono e prendono spazio nell’unico posto dove devono farlo…
Quelle diciannove composizioni che già conoscevamo sembrano nascere per la prima volta, dentro ai loro impulsi, frenesie, con la cortesia di chi non vuole disturbare portando invece in dono una ricchezza incalcolabile.
Le tre inedite sono germogli di stupore in avanzamento, atti continui di una classe che non ha bavagli né bende: Adrian è un fuoco fatuo davanti al tramonto, e tutte e tre confermano la misura di un talento senza sosta.
Carlo e le persone che ancora oggi sostengono il valore di Adrian ci deliziano con questa fascia purpurea che non è una rivisitazione o un miglioramento di materiale già edito.
Bisogna ascoltare con attenzione perché qui siamo al cospetto della nascita di voli che saranno capaci di portarci con lui dentro il suo universo. Occorre rispetto e consapevolezza.
Non esiste lamentela, delusione o pretesa davanti a questo insieme di brani. Bensì la premura nell’adoperarsi in una ricerca che se fatta bene sarà fruttuosa: lui è una certezza.
Il lato acustico dell’autore Londinese è quello della perfezione che non è data dall’assenza di errori tecnici o imprecisioni, bensì dal frastuono che genera il sentire tutta la purezza che non necessita di altri strumenti: è tutto generosamente offerto in questa ampolla luminescente, dove forza e debolezza convivono insieme nella magia che genera stupore.
Raffinate, estroverse, introverse, ammalianti, tristi e veritiere, sono tuffi continui nel suo mondo dalle finestre chiuse, mentre Adrian ci mette a disposizione la gittata del suo sguardo.
Ascoltando ti rendi conto di come il silenzio sia stato gentile con lui: gli ha permesso di penetrarlo con accortezza, senza invasioni. Queste canzoni sono il confine tra l’esercizio artistico e il suo incontro, dove tutto si appoggia alla meraviglia.
Ti ritrovi a dimenticare quello che è successo, non piangi per la sua assenza, non ti tormenti, non urli ma taci mentre le dita delle sue mani sulla chitarra e la sua voce ti conducono alla sua sensibilità, prendi appunti, non canti le sue parole, spegni ogni atomo di presenza e lo lasci libero di chiacchierare intimamente con il tuo bisogno di contatto con la sua anima, lucida e potente.
Lui ci dimostra che i sogni si possono toccare, specialmente quelli che si infrangono contro una realtà contraria. Non ci resta che capire che dobbiamo camminare con i suoi pensieri in una direzione opposta a quella dei desideri ed è in quel momento che sentiamo il suo respiro soffocare, la testa impazzire e il cielo cadere. Si piange tantissimo ascoltando questo album, perché la tristezza punge la pelle.
Forse dovremmo immaginare che lui fosse felice solo cantando e suonando: potrebbe essere una supposizione inevitabile. Ma non lo si ama per questo capriccio, bensì per la certezza che non abbia lasciato sfuggire nulla di sé nelle canzoni, che si sia speso nella lealtà. Sono ventidue doni che non ingombrano, non disturbano lo spazio ma generano un vulcano in eruzione perenne, dove ciò che sbava è la malinconia che si eleva a essere la fedele compagna. Patimenti, frustrazioni e tristezza si presentano e dobbiamo tenerne conto: può essere uno tsunami, dovendo decidere se lasciarsi travolgere o costruire in tempo la modalità che possa spegnerne la potenza.
Impossibile.
Andiamo a vedere da vicino le sue canzoni, con tremore e rispetto, in generosa modalità di una propensione all’attenzione, consci in anticipo del fatto che non saremo capaci di comprendere sino in fondo tutta la sua arte, ma saremo consolati dal sapere che in ogni caso sarà puro stordimento…
P.s. Non commettiamo l’errore di pensare che esista una parte migliore di Adrian e che appartenga al periodo del meraviglioso combo chiamato The Sound. Ciò che Adrian ha fatto successivamente ha la stessa valenza e capacità di scrivere canzoni maestose. Le comparazioni lasciamole agli stupidi, agli ignoranti, perché non essere in grado di capire che quell’uomo fosse incapace di scrivere cose brutte significa ammazzarlo una seconda volta…
Song by Song
1 Scales Of Love And Hate
“Seems like we've shut and locked every door
The deeper the cut, the colder the war”
Si incomincia con i sogni che crollano, a confermare la distanza tra loro e la realtà, nell’impossibilità che si fa palpabile. Ed è un brano che scalda immediatamente, la chitarra ritmica e la voce che cade sul microfono, tenerissima.
2 Love Is Such A Foreign Land
“You're not easy to forget
But you're no reason to get upset”
Anche gli angeli fanno i bagagli e hanno sicuramente questa voce mentre decidono la destinazione. La chitarra, tenuta quasi nascosta, mostra di essere perfetta per il cantato, sussurrato, che vola tra i registri bassi e quelli alti sino a sfiorare il falsetto.
3 Weekender Berliners
“Maybe I see you again, maybe I never will
But I'll always have this picture that I hold very still”
Un arpeggio vola su, nella voce di Adrian, e tutto è sottile, dentro una storia che scivola, senza rimpianti, mentre i brividi si raccolgono.
4 Falling Off Your Horse
“I've tried to ride your dark wild eyes
Took a breath of air twelve feet up there
And then I tasted sand”
Tra equilibri perduti e ciò che si deve pagare di conseguenza il brano mostra un ritmo vorticoso, rigorosamente acustico, e il cantato breve di Adrian, tutto versato nel vuoto con grande intensità. E sono accordi che scuotono, sono parole che fanno gonfiare gli occhi mentre la voce ci porta a cavalcare nei prati della vita.
5 Downtown
“I could be the ocean
Crashing into your land”
La voce inspira, le parole escono vibranti, e si sale in macchina con lui per scendere in città con una canzone che manifesta la sua intensità, abbottonata a una melodia efficace, per ricordarci che la sua ugola sa avere artigli meravigliosi.
6 Tired Man
“These eyes are closing now
I've got nothing to say”
L’atmosfera rallenta, echi di un passato remoto mostrano il volto in questo testo breve ma capace di suscitare sobbalzi in un cantato che mostra quanto Adrian e Jim Kerr avessero molto in comune. Ma qui ci si emoziona, ci si sente abbattuti angelicamente, e la stanchezza esce dalle sue labbra mentre la chitarra accelera il suo ritmo.
7 Unkissable
“Oh your sideways glance is like a lance
And your whisper seems to shout”
Il primo dei tre inediti è scritto insieme a Carlo ed è anima blues e country che viaggia dentro il buco di una testa che fa fuoriuscire lava e grigiori. Incantevole, amara quanto basta per entrare nei nostri bisogni.
8 Street Of Flowers
“And with smiles set back into stone again”
Il secondo brano pare provenire dalla nebbia della periferia di un geyser, cupa e toccante, con una scia di luce che sembra essere presente per sbaglio. Adrian ha una voce che smuove ogni strada con i fiori che si inchinano, silenziosi. Un sussurro notturno meraviglioso.
9 The Sea Never Dies
“Still the heart is an ocean and the sea never dies
Love comes and goes like the sun and moon”
Ultima canzone inedita: ecco la ballad per eccellenza arrivare, toccare le ombre in movimento per poterci raccontare una storia fatta di parole e amore, con le dita sulle chitarre che scivolano ed emettono un rumore che è poesia. Tutto è delicato ma non timoroso, per un brano che esplode nel cuore e non nel suono…
10 Our Forest Ghost
“Our forest ghost is looking out for us
Two hundred years he watched that clearing “
Questa voce ti sequestra, uscita da un miracolo che ci trova sempre impreparati. Tutta la dinamica del suo cantato lo puoi trovare qui, passato e presente che prendono possesso in questo brano della loro necessità di non separarsi neanche per un attimo. E si sogna mentre si ascolta la colonna sonora di un film, quella del suo talento.
11 Time Standing Still
“The moment you turn to go
Everything seemed to slow”
L’amore cura ma è anche la ferita, e te ne accorgi dalla voce di Adrian che sembra abbandonare il pianeta in anticipo in questa esibizione folk che oltrepassa le nuvole.
12 Walking In The Opposite Direction
“And every day the things you crave
Make a play for my affection”
Per lo scriba è arrivata la tempesta, il momento che assolutamente gli devasta il cuore, saranno gli accordi tristi e immensi, sarà la voce di Adrian che trova assolutamente l’ingresso del paradiso piangente, saranno le parole soffocanti, sarà l’anarchia che rende liberi ma sicuramente non felici, che fanno di questa canzone un pugno ripetuto, senza che gli si riesca a sfuggire…
13 Excavation Bones
“So you peeled away the skin
Past the ribs straight to the sin”
Ecco l’appuntamento con l’oscurità più densa e rivelatrice della solitudine come conseguenza, dentro note basse della chitarra che sembra bussare al nostro inconscio sino a che il ritmo giunge insieme a questa interpretazione vocale che ci stende per terra, con il testo colmo di immagini fragorose a cui non riusciamo a sostenere…
14 Running Low On Highs
“I took my pleasures one by one
Hovered closer to the sun”
Si cade, dentro a una ritmica che seduce per sensualità, mentre invece le parole suggeriscono pensieri che affaticano la felicità e le sicurezze. La musica ha più spazio ma poi, quando le note si fanno vive, Adrian ci fa cadere con lui…
15 Valentine
“Unwelcome lodgers in my head”
L’amore non è immune da ciò che è sgradevole e qui ne abbiamo la dimostrazione: con una chitarra nei pressi dei Doors, la storia si fa netta subito e tutto si trascina verso l’amara consapevolezza, con la chitarra che scende sino al nostro ventre… Scritta con Carlo.
16 The Last Days Of The Rain Machine
“We sucked this world down to its brittle bones”
Adrian Borland è uno straordinario scrittore di testi: sa adoperare l’ascolto per trasformarlo in semi, spesso amari e indiscutibili. Purtroppo, la sua maturità è figlia del dolore e in questo brano ve n’è molto. La chitarra disegna schegge di pioggia e la sua voce cade pesante, nel racconto di un qualcosa che finisce…
17 Snakebitten
“You say I should have learned by now
Yet I've only learned to forget”
Il ritmo diventa un ramo che ci sposta, bello compatto, con la voce angelica che raccoglie tempesta, tra morsi e cose da dimenticare. Molto 80’s, un mantra che conquista, sconquassando.
18 Inbetween Dreams
“A great slab of day gets in the way
Of where you want to be
Breathing out, breathing in”
Seducente, accattivante nella parte musicale, una danza acustica che si trova dentro le parole che si riferiscono al tempo, il padrone assoluto di tutto. E la voce si fa veleno e spina sino ad abbandonarsi ai sogni.
19 Hallucinating You
“Heat-haze at your edge
Where you protecting me”
La confusione arriva con una serie di domande a raffica, mentre tutto ha l’umore tetro di una perdita in arrivo.
20 Wild Rain
“I don't belong here, I belong to the storm”
Adrian ci porta nei suoi vertici artistici, con un gioco di ruoli, fatto di domande e risposte, mentre la splendida chitarra fissa la perfezione.
21 Four Lonely Hours Away
“Waiting for the early trains
Kicking cans in the square
Funny how it always rains
On people going nowhere”
Mi scuso, ma su questa non posso scrivere nulla: solo lacrime…
22 Dead Guitars
“Now I see all these new faces
And they look to me like a row of trees
And of all the friends that have now departed”
Quando muore tutto, anche una chitarra, l’elenco delle scomparse trova il suo arresto, l’immobilità che apre le porte alla vita eterna, senza garanzia che ci sia qualcosa di meglio. L’ultimo brano consacra la sua vena poetica con la violenta amarezza sui bordi di labbra pronte per morire insieme alla loro chitarra…
È possibile ordinare l'album qui: soundshaarlem@gmail.com
Un ringraziamento speciale a Jean-Paul van Mierlo per il suo contributo alla promozione della musica e dell'anima di Adrian e per il suo meraviglioso lavoro artistico.
Alex Dematteis
Musicshockworld
22 Novembre 2022